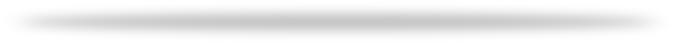* * *
Vi racconto una favola di Esòpo: c’era una volta una montagna che stava per partorire. Le doglie si facevano sempre più intense, dalla cima cominciò ad uscire fumo e la terra tutt’intorno tremava. Gli abitanti dei villaggi vicini temevano che qualcosa di terribile stesse per accadere e si riunirono a pregare, fin quando una scossa violentissima alzò un’enorme nuvola di fumo. Tutti caddero in ginocchio e, quando la nube si dissolse, ecco che dalle rocce fumanti spuntò un topolino.
Cosa c’entra questa favola col tema della giustizia?
C’entra, perché ci aiuta a comprendere una questione centrale, cioè la differenza tra la verità storica e la verità processuale.
È fondamentale capire che questo tema non si pone soltanto per i processi che assumono un grande rilievo mediatico. In questi casi, infatti, siamo portati a credere che la delusione che spesso proviamo all’esito del giudizio sia causata dall’eccessiva aspettativa di giustizia che si era ingenerata nell’opinione pubblica.
E invece no, la sgradevole sensazione di una risposta insoddisfacente la si prova spesso anche nelle cause di scarso significato. È proprio un fatto strutturale: si ha sempre l’impressione che la montagna delle nostre aspettative partorisca un misero topolino. E questo perché?
Semplice, perché i tribunali non sono luoghi deputati a rendere la verità, ma solo la verità processuale, che è ben altra cosa. Il processo non tende alla verità, ma alla formazione di un giudicato, quindi la verità processuale è una verità di tipo convenzionale, nulla di più. E allora dobbiamo pensare alla verità processuale come alla caricatura della verità, come a qualcosa che la scimmiotta, che cerca di assomigliarle ma che - fatalmente - ne sarà una sbiadita controfigura.
La verità che vien fuori dal processo è inevitabilmente più angusta e striminzita di quella storica, perché non tiene conto di tutta una serie di circostanze che nel processo non possono entrare. Al processo hanno accesso solo quei fatti che possono essere provati. Ma soltanto una minima parte degli eventi che viviamo ogni giorno potrebbe esser dimostrata in giudizio, mantenendo peraltro intatte le caratteristiche che i fatti presentavano nell’accadimento reale.
Quindi, il recinto delle cose che hanno rilievo ai fini del giudizio si restringe di molto e le cose che pure riescono ad entrarvi difficilmente mantengono lo stesso colore originario. Ecco perché la verità processuale spesso ci delude.

Ma c’è anche un’altra ragione che sta alla base di questa costante delusione.
Mi riferisco al fatto che noi occidentali siamo convinti che la verità sia l’esito di un conflitto. Dobbiamo riconoscere che, per la nostra cultura, la guerra ha un valore costituente e il processo giudiziario finisce per essere la rappresentazione incruenta di tutto ciò. Il processo è un confronto dialettico che - nelle nostre aspettative profonde - conduce necessariamente alla verità. Per rendersi conto di quanto sia radicata in noi questa convinzione, basti pensare che tutti gli elementi fondativi del mondo classico e del pensiero occidentale sono l'esito di uno scontro: gli dèi dell’Olimpo altro non sono che la “cosca” vincente di una guerra tra dèi che si è svolta al principio dei tempi; la guerra di Troia è stata la scintilla che ha fecondato la cultura dei millenni successivi; il dialogo è unanimemente considerato come il propellente per la nascita del pensiero filosofico.
Insomma, noi siamo profondamente convinti che dal confronto nasca la verità. Ecco perché la verità processuale ci delude, proprio perché ci accorgiamo che spesso dalla dialettica giudiziale viene fuori qualcosa che non può poter essere chiamata verità.
E poi, come nella favola della montagna che partorisce il topolino, man mano che il processo va avanti, le parti vedono lievitare le proprie aspettative; per una strana legge fisica, le loro attese si gonfiano, come se il trascorrere del tempo fosse una specie di pompa. E così la delusione è assicurata.
E arriviamo, allora, al punto centrale della faccenda: il dramma del processo consiste nel fatto che il giudice deve decidere.
O meglio, il dramma sta nel fatto che il giudice, per poter decidere, deve necessariamente limitare l’uso pieno della propria ragione, ricorrendo ad una serie di artifici consapevoli e di finzioni logiche:
- deve anzitutto ridurre la complessità dei fatti storici che è chiamato a giudicare, trattando i fatti storici come fossero semplici dati di natura (equiparando, cioè, comportamenti umani a dati di natura, più agevolmente giudicabili e sanzionabili);
- deve poi porre un freno a quel procedimento logico che più d’ogni altro caratterizza la ragione: il dubbio. Proprio così, il giudice è chiamato a tagliare il cattivo infinito del dubitare.
Ma, se l'atto stesso del decidere è costretto a limitare l'uso pieno della ragione, allora la verità processuale sarà destinata a deluderci sempre … quindi - dalla nuvola di fumo sollevata dalla montagna delle nostre aspettative che fragorosamente partorisce - uscirà per forza un misero topolino.