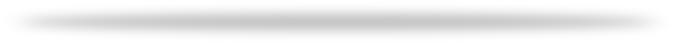***
Pastorale americana è un romanzo di Philip Roth. La storia sembra una di quelle che piacciono tanto agli americani, perché narra del fallimento di una vita, di una famiglia, di un intero Paese addirittura. Insomma, un fallimento epocale.
Quel che sorprende di questa storia non ha tanto a che fare con la perenne ossessione degli americani che venga infranto il loro celeberrimo sogno. Qui non c’entra la paura di non riuscire che tanto li affligge. A questo siamo abituati, questo non ci stupirebbe: la letteratura americana ce l’ha detto e condito in tutte le salse.
Pastorale Americana, invece, svela una ben più profonda verità, perché ci costringe a riflettere su quanto la vita possa essere ingiusta, inaspettatamente e inspiegabilmente ingiusta, contro ogni pronostico e ogni demerito.
Per rendercene conto è sufficiente ripercorrere la storia di colui che - nell’immaginario di ciascuno di noi - è il vincente per definizione, colui che incarna l’invincibilità passata, presente e futura: il campione del college, “er mejo figo der bigoncio”. Si tratta del ragazzo più bello, più dotato nello sport, quello più affascinante, spigliato con gli insegnanti e irresistibile per ogni ragazza. Per di più è ricco, di buona famiglia e di ottima salute.
Ecco, il protagonista di Pastorale Americana è proprio lui ed è soprannominato “Svedese”. Sposa la ragazza più bella della contea, la quale è peraltro di sani principi, volitiva, determinata e affettuosa. Subentra nella gestione della fabbrica paterna e mette su una bella famiglia. Conduce la propria azienda in maniera umana ed efficiente. E’ cordiale e signorile con tutti. Si preoccupa della figlia, che segue con affetto e attenzione. E’ un uomo laborioso e fedele, ma la figlia - crescendo - viene sopraffatta dalle violente ideologie di contestazione che imperversavano tra gli anni sessanta e settanta fino a diventare una terrorista assassina. Lo Svedese resta sempre accanto alla famiglia che intanto si sfascia inesorabilmente, ritrova la figlia e cerca in ogni modo di riportarla a casa, resta accanto alla moglie che ormai lo tradisce accusandolo di essere la causa di ogni infelicità.
Insomma, un mondo perfetto si sfalda nelle mani incolpevoli di un uomo buono, devoto e ricco di ogni qualità, il vincente per definizione su cui tutti avrebbero scommesso. Roba da non credere. Tutte le doti e le virtù immaginabili non sono riuscite ad evitare un’ecatombe epocale. Una storia che farebbe impallidire perfino Giobbe!
E allora bisogna fermarsi e riflettere su un aspetto che adesso ci appare di una semplicità disarmante: non sta scritto da nessuna parte che la vita sia giusta, né che debba esserlo. Questo ci terrorizza, ma è sotto gli occhi di tutti, dovunque e in ogni momento. Siamo naturalmente affezionati all’idea di un ordine retributivo che agisca qui ed ora, in forza del quale ognuno debba ricevere quel che si merita, tutto sommato. Ma non è così. Non è vero.
I nostri comportamenti non garantiscono nulla, non determinano automaticamente i risultati in vista dei quali la nostra vita è stata costruita. Questa semplice constatazione ci destabilizza, perché ci mostra con crudele evidenza che noi non bastiamo a noi stessi, che non riusciamo a spiegare e a determinare la nostra esistenza. Tutto questo ci fa vivere nell’angoscia.
Il merito più evidente di Pastorale americana - al di là dei profili sociali e storici che costituiscono la cornice del racconto - è proprio questa presa di coscienza. Se neppure il campione del college, l’invincibile idolo di un’intera generazione - per di più dotato di ogni virtù e benedizione - riesce a conseguire risultati accettabili, allora vuol dire che questa clamorosa ingiustizia significa ben altro che un semplice fallimento: non può trattarsi di fallimento se non c’é colpa e se si posseggono tutti i talenti necessari per conseguire l’impresa.
E forse, allora, quest’ingiustizia denuncia qualcosa di più radicale, di più profondo rispetto al fallimento del sogno americano. Qui non si tratta dell’arrancare dei più lenti, di coloro che restano indietro, come oggi si ama dire. Qui è il campione che fa cilecca. Qui entra in crisi la nostra stessa idea preconfezionata di giustizia, ci accorgiamo cioè che 2 + 2 non fa sempre 4, che i conti spesso non tornano.
Lo Svedese è una sorta di Giobbe dei nostri giorni e come Giobbe ci costringe a riconsiderare il mistero della nostra esistenza, che deve necessariamente aprirsi a dimensioni più grandi se vuole sperare di non affogare in un oceano di non-senso. Lo Svedese era il nostro mito al tempo del liceo e deve esserlo ancor’oggi, perché ha la forza di urlarci in faccia la necessità di sbarazzarci dell’habitus mentale del ragioniere. Le cose non vanno quasi mai nel modo previsto, a un’azione non consegue meccanicisticamente una determinata reazione. Non è vero che alla fine del campionato i punti persi e guadagnati si compensano.