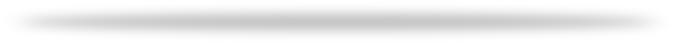***
Sono tanti i gerghi che vivono nelle nostre società: il linguaggio di formule e frasi fatte della Pubblica Amministrazione (burocratese), della Sanità (medichese), della tecnologia (tecnichese) o delle norme di convivenza e della legge (legalese). Il gergo però non è solo un linguaggio che ghettizza chi non lo sa usare: isola anche la comunità che lo ha generato e la chiude a ogni cambiamento. Il linguaggio non è statico: evolve con i bisogni della comunità e delle persone che la compongono.
Ma cosa s’intende con inclusione? Maggiore capacità di ascolto, accoglienza, rispetto e una più aperta convivenza tra le identità o diversità che esistono in qualsiasi studio legale.
Con il crescere dell’attenzione intorno al tema del linguaggio in Italia, si è però anche molto inasprito il dibattito, che a volte sembra centrarsi “solo” su questioni di genere o identità di genere.
Mi riferisco alle diverse posizioni, che è possibile incontrare, relativamente per esempio all’uso dei femminili nelle professioni: sindaca, avvocata, ingegnera. Termini che incontrano ancora molta resistenza, nonostante siano corretti da un punto di vista morfologico e semantico e che altro non fanno che individuare il genere della persona che ricopre un ruolo.
Altro aspetto oggetto di discussione, riguarda l’utilizzo di desinenze neutre nell’italiano, come lo schwa, l’asterisco o la chiocciola, per ridurre l’utilizzo del cosiddetto “maschile sovraesteso”. Per esempio, forme come “Buongiorno a tutti”, “Cari colleghi” possono essere sostituite con “Buongiorno a tutt*”, oppure “Carə collegə”. Si tratta di formule più inclusive a livello del genere, che però al momento non sono ancora riconosciute dai principali lettori di schermo e che potrebbe rendere un testo poco accessibile ad alcune categorie di persone con disabilità sensoriali o forme di neurodivergenze.
Ma il dibattito non si esaurisce a questioni di questo tipo, seppur rilevanti.
Il ruolo del linguaggio, utilizzato all’interno (così come all’esterno) di qualsiasi azienda e studio legale è essenziale su molti fronti.
La lingua giuridica diventa spesso una fonte di marginalizzazione e di esclusione attraverso un vocabolario iniziatico che crea barriere nel momento in cui legittima abusi e privilegi. Come ben sottolineato nel libro “Scrivi e lascia vivere” di V. Di Michele A.Fiacchi A.Orrù, la sfida per l’inclusività della comunicazione giuridica non si vince solo con un richiamo alla semplificazione del linguaggio anche se “la cura delle parole è esercizio di democrazia” (G. Zagrebelsky). Cosa rende inclusivo il linguaggio giuridico e della magistratura? Partiamo dalla sentenza che ha una funzione di conoscenza: racconta un fatto e l’iter logico che ha portato al giudizio a che ne è interessato e alla collettività. Per raggiungere questo obiettivo due sono i requisiti fondamentali: chiarezza e sintesi.
Chiarezza in ambito legale significa scrivere testi che non fanno selezione tra chi li legge ma che includono quante più persone possibile. Sintesi è scrivere testi che rispettino la funzione di conoscenza con la massima economicità di mezzi (“Comunicare: un compito inutile?” G. De Cataldo). Un linguaggio migliore favorisce la comprensione, apre il dialogo, riduce l’odio sociale e le discriminazioni. Riduce anche la degenerazione informativa che determina la febbre giustizialista di social e media.
Uno dei teorici del movimento del plain language, Robert Eagleson, linguista australiano, lo ha definito un linguaggio che usa solo le parole necessarie, non certo per questo di livello infantile, limitato o povero, ma in grado di fare arrivare il messaggio senza imporre inutili fatiche e perdite di tempo ai suoi destinatari.
La lingua del potere e del diritto continua a trincerarsi dietro formulazioni vuote, generiche e astratte, che ne consentono un uso distorto e manipolatorio.
Come ricorda Gianrico Carofiglio nel suo saggio “Con parole precise. Breviario di Scrittura Civile” Churchill il 9 agosto 1940 mandò a tutti i membri del suo governo un memorandum intitolato “Brevity”, in cui la prima cosa che invitava a fare era eliminare frasi e parole inutili. “Si metta fine a frasi – scriveva lo statista inglese – come queste: è altresì di estrema importanza tenere presenti le seguenti considerazioni; oppure dovrebbe essere presa in considerazione la possibilità di porre in essere. La definiva vuota verbosità. Dell'inutilità di simile uso della lingua ogni commento è superfluo. Errore: serve, serve eccome a chi la usa per esercitare il potere pro domo sua e non a vantaggio di chi lo ha legittimato al ruolo”.
“A plain language is a civil right”, ha detto Al Gore, ex vice presidente degli Stati Uniti.
Stesso concetto espresso così da Tullio De Mauro “Le parole sono fatte, prima che per essere dette, per essere capite: proprio per questo, diceva un filosofo, gli dèi ci hanno dato una lingua e due orecchie. Chi non si fa capire viola la libertà di parola dei suoi ascoltatori…peggio se è un giornalista, un insegnante, un dipendente pubblico, un eletto dal popolo. Chi è al servizio di un pubblico ha il dovere costituzionale di farsi capire.”
L'uso della lingua come imperativo morale
Come scriveva Italo Calvino, una lingua figlia del “cercare di pensare e d’esprimersi con la massima precisione possibile proprio di fronte alle cose più complesse” e, come tale, “unico atteggiamento onesto e utile. Nei discorsi approssimativi, nelle genericità, nell’imprecisione di pensiero e di linguaggio, specie se accompagnati da sicumera e petulanza, possiamo riconoscere il diavolo come nemico della chiarezza”.
Farsi capire è un imperativo morale perché scrivere chiaro e semplice è già usare un linguaggio inclusivo.