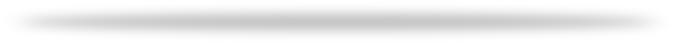***
La questione dei porti chiusi
“Non ti allarmare fratello mio… dimmi, non sono forse tuo fratello”?
Tesfalidet Tesfom è l’autore di questi versi: null’altro che un migrante deceduto il giorno dopo il suo sbarco a Pozzallo avvenuto il 12 marzo 2018 dalla Proactiva, una nave della ong spagnola Open Arms. Braccia magre, viso scavato e sofferente, occhi pieni di dolore è ciò che resterà indelebilmente impresso in quanti hanno fatto il possibile per salvare quel ragazzo che al momento del suo arrivo nel nostro paese pesava appena trenta chili. Tesfalidet è morto a causa della malnutrizione e di una tubercolosi in stato avanzato che gli aveva perforato un polmone: riusciva a malapena a camminare quando il medico degli sbarchi, il dott. Vincenzo Morello dell’Usmaf del Ministero della Salute, lo ha soccorso. «Gli ho chiesto perché era in quelle condizioni e lui ripeteva Libia… Libia», racconta. Segen – questo lo pseudonimo con cui firmava le sue poesie - è morto in Italia a causa della Libia. Già, proprio quella Libia così sicura ed accogliente alla quale andrebbero rispediti i migranti tanto indesiderati.
Indipendentemente dal proprio credo politico vicende come quella di Tesfalidet e, con essa, la questione dei porti chiusi in Italia tornano periodicamente alla ribalta sia che si stia entrando in campagna elettorale, sia che ci si approcci semplicemente ad un qualsiasi altro dibattito, sicuramente anche grazie ai mass media che sono in grado di informare come di disinformare a riguardo.
Eppure, per quanto nella Costituzione italiana non venga espressamente prevista una disposizione che tuteli il diritto alla vita, [1] a partire da San Tommaso d’Aquino coloro che hanno studiato i diritti umani lo hanno considerano come il primo tra quelli fondamentali, al punto che esso risulta solennemente proclamato in tutte le Carte internazionali e sovranazionali a disposizione del mondo occidentale: dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo al Patto internazionale sui diritti civili e politici, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
In particolare, l’art. 2 della CEDU stabilisce che «il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge e nessuno può esserne intenzionalmente privato», mentre l’art. 3 precisa che: “nessuno venga sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti”. Pertanto, le violazioni degli artt. in questione possono essere attuate tanto da soggetti pubblici quanto da privati, in contesti detentivi e non solo, ben potendo immaginare che questi ultimi siano rappresentati anche dai centri dedicati agli immigrati.
Il principio di non respingimento
In realtà, del fenomeno migratorio si parla molto perché, scontato dirlo, è innegabilmente collegato alla volontà di intraprendere una nuova gestione dei flussi provenienti principalmente dalle coste della Libia non considerando, tuttavia, che il principio fondamentale del diritto dell’immigrazione – e, quindi, anche del CEAS − è quello del non-refoulement (non respingimento). Tale principio ci ricorda che “non può essere espulsa o respinta nessuna persona che rischia di essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto da tali situazioni, sicché la sua vita o la sua libertà potrebbero essere seriamente minacciate”.
Originariamente riconosciuto nell’ambito del diritto internazionale grazie all’art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951, attualmente configurato nell’art. 78 TFUE come il fondamento della “politica comune unionale” in materia di asilo [2] risulta essere, altresì, il protagonista di diverse pronunce che si sono espresse sul punto tra le quali menzioniamo la sentenza della Grande Sezione della CGUE del 14 maggio 2019, cause riunite C‑391/16, C‑77/17 e C‑78/17 per il suo carattere innovativo.
Dell’ampia motivazione - basata su un’interpretazione sia della direttiva 2011/95/UE, sia della Convenzione di Ginevra - colpisce quest’affermazione: “la perdita dello status di rifugiato a seguito della commissione di delitti particolarmente gravi o per questioni di sicurezza nazionale, non può comunque comportare il rimpatrio nel paese d'origine, se lì è messa a rischio la vita dello straniero”.
I giudici hanno sostanzialmente sostenuto che benché la Convenzione di Ginevra consenta, nei confronti di coloro che rappresentano una minaccia per la sicurezza o sono stati condannati per un reato particolarmente grave, l'espulsione e il respingimento - quando cittadini stranieri o apolidi -, essa comunque non prevede la perdita dello status di rifugiato. Pertanto, lo status di rifugiato ha natura meramente ricognitiva e non costitutiva di tale qualità: fintanto che il cittadino di un paese extra-UE o un apolide abbia un fondato timore di essere perseguitato nel suo paese di origine o di residenza, questa persona dev'essere qualificata come rifugiato ai sensi della direttiva e della Convenzione di Ginevra e ciò indipendentemente dal fatto che lo status di rifugiato ai sensi della direttiva le sia stato formalmente riconosciuto.
In definitiva, per la Corte la direttiva dev'essere interpretata e applicata nel rispetto dei diritti garantiti dalla Carta che vieta, in termini categorici, la tortura, le pene e i trattamenti inumani o degradanti, a prescindere dal comportamento dell'interessato.
Conclusioni
L’evoluzione in senso garantista della giurisprudenza europea, se correttamente intesa, potrebbe condurre al consolidarsi di prassi più rispettose dei diritti fondamentali e della dignità dell’essere umano. Per quanto sia comprensibile e necessario garantire una corretta gestione del fenomeno migratorio, in ogni caso essa non può essere unicamente demandata allo stato ospitante.
“Il mondo attuale è suddiviso in una molteplicità di Stati che si fronteggiano e si fiancheggiano. Per i figli della nazione, che sin dalla nascita hanno condiviso l’ottica statocentrica, lo Stato appare un’entità naturale, quasi eterna. Ecco perché riflettere sulla migrazione vuol dire anche ripensare lo Stato.
Migrare non è un dato biologico, bensì un atto esistenziale e politico e nei libri di storia si dovrà raccontare che l’Europa, patria dei diritti umani, ha negato l’ospitalità a coloro che fuggivano da guerre, persecuzioni, soprusi, desolazione, fame. Anzi, l’ospite potenziale è stato stigmatizzato a priori come nemico, mentre chi era al riparo, protetto dalle frontiere statali, di quelle morti e di quelle vite porterà il peso e la responsabilità” [3].
Riconoscere l’esistenza “dell’altro” vuol dire aprirsi non solo ad un’etica della prossimità, ma anche ad una politica della coabitazione da intendersi nel suo senso più ampio e profondo. Non si tratta di stare l’uno accanto all’altro, ma di favorire una convergenza temporale in cui il passato di ciascuno possa scandire il presente, in vista di un comune futuro.
[1] Tuttavia, nell’art. 27, quarto comma la nostra Carta fondamentale prevede il divieto della pena di morte per il quale, insieme ai valori ad esso sottesi, si impone una garanzia assoluta.
[2] Mentre nel nostro ordinamento si collega a quello di asilo ex art. 10, terzo comma, Cost.
[3] Sul punto Di Cesare D., “Stranieri residenti. Una filosofia della migrazione”, Bollati Boringhieri, 2017.